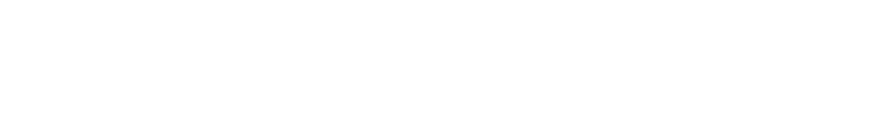Roma, 7 novembre. Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore e del quotidiano “l’Unità”, l’interessante articolo di Furio Colombo dedicato non tanto alla vertenza contrattuale quanto all’attuale grave situazione del mondo dei giornali e alla contrapposizione radicale tra gli “editori di adesso” e i “giornalisti di una volta”. Una analisi lucida e impietosa del mondo dell’informazione, del caporalato giornalistico: “La funzione terza del giornalista – scrive Colombo – non interessa più. Il giornalista già legato da un rapporto di fiducia con i lettori è una palla al piede, se per caso dissente dall’editore”. Da qui nasce, aggiungiamo noi, l’abuso dei contratti a termine, dei co.co.co, di ogni forma di precariato, di una flessibilità selvaggia e esasperata e, specularmente, la messa in atto all’interno dei giornali, in maniera sempre più massiccia, di azioni di mobbing contro i giornalisti con più esperienza, più autonomia, o semplicemente più sindacalizzati. Per mandarli via.
Ecco qui di seguito l’editoriale dal titolo “Editori e giornalisti”, di Furio Colombo (l’Unità, 5 novembre 2006):
“È questione di una o due settimane e poi lettori dei giornali e spettatori della televisione leggeranno o ascolteranno di nuovo il messaggio detto da «chi vi parla è autorizzato dal Comitato di Redazione». Dirà che i giornalisti sono ancora costretti a uno, due o tre giorni di sciopero, perché gli editori non intendono firmare il contratto.
Vorrei rassicurare chi legge. Questo non è un intervento sindacale. Altri hanno quel compito, e lo svolgono con impegno. Questa è una storia italiana. Ma è già stata, prima di noi, storia di altri paesi. Una insofferenza profonda ha cominciato a soffiare come un ghibli contro la professione di informare. Quel ghibli è stato – e continua ad essere – così violento da deformare tutto il paesaggio della professione giornalistica e delle figure che in essa operano al punto che non sempre le puoi riconoscere. Ci sono giornalisti che celebrano festosamente i giorni di sciopero di altri giornalisti, irridendoli e continuando il loro lavoro indisturbati, come se avessero un “passi” o una visione radicalmente diversa della vita professionale. Per esempio: «Ma quale contratto? Si può benissimo lavorare senza, se sei dello stesso partito del padrone. I compensi arrivano in tanti modi». Ci sono giornalisti che fanno finta di non vedere, perché stanno percorrendo una loro strada diversa (per esempio «il quotidiano di proprietà dei giornalisti»). Tutto giusto, se questo fosse una normale, antipatica, difficile disputa economica, quanti soldi in più per questo o per quello.
Ma questa non è affatto una disputa economica. La questione che stanno ponendo gli editori italiani – o almeno chi li guida – è molto più seria e radicale, e dovrebbe riguardare tutti coloro che sono coinvolti in questo mestiere, se non altro come cittadini. Dovrebbe riguardare (se ci fossimo spiegati e ci fossimo fatti capire) tutta l’opinione pubblica. La questione è questa: con l’immenso flusso informativo a disposizione nel mondo, che bisogno c’è dei giornalisti, ovvero della funzione professionale che da oltre due secoli questa categoria va svolgendo? Le aziende editoriali sono in grado di intervenire in ogni momento su tutto, a partire da un vasto materiale comunque disponibile. Quel che serve è il montaggio del materiale e la spalatura delle scorie, ovvero un brulicare di giovane manodopera precaria intercambiabile, simile a quella delle fabbriche elettroniche, in cui conta più l’agilità delle dita che la qualità della testa (anzi, conta solo l’agilità delle dita). E dunque del “giornalista professionista” – come noi amiamo pomposamente definirci – non si sente più alcun bisogno; e tanto vale usare questa battaglia contrattuale per dirlo adesso e concludere un capitolo durato fin troppo a lungo nella storia dell’editoria. Non credo che sia esagerata questa rappresentazione del punto del contendere. Si può semplificare così: dei giornalisti non c’è più bisogno. Le notizie piovono dalla rete. Quanto a editoriali, corsivi e commenti, bastano e avanzano piccoli gruppi di punta affini alla proprietà. E il ricco mercato di voci disponibili nelle professioni umanistiche, economiche, scientifiche. Il mercato (la domanda) individua, seleziona, premia quelle voci. E dunque si forma abbastanza rapidamente un serbatoio sicuro al quale attingere. Perché è naturale che “le voci di fuori” (per parafrasare Edoardo De Filippo, le sue Voci di dentro, nella bella versione che Francesco Rosi ha messo in scena con Luca De Filippo in un teatro di Roma) rispondono a un mercato che offre molto a chi ha da dire le cose giuste.
Le cose giuste sono quelle che rappresentano – il più da vicino possibile – le posizioni degli editori, quelle che riflettono interessi, quelle che riflettono scelte, quelle che annunciano o rappresentano interventi in un campo o nell’altro della vita pubblica, i temi morali, le decisioni politiche, le leggi di un governo, le opzioni internazionali. Ma anche le autorizzazioni e i permessi, che riguardano gli specifici campi di attività di vari editori, che sono tutti imprenditori, attivi in molti campi, che coprono quasi tutti i settori regolati dai governi e svolgono attività – come le intercettazioni – che alle attività dei governi si sovrappongono. Si forma così un “caporalato” dell’intervento politico o economico, in cui l’editore-caporale non ha difficoltà a uscire sulla piazza (universitaria, professionale, scientifica, ma anche di schieramento e competenza morale e religiosa) per assumere di volta in volta le voci più consone. Quelle voci, a loro volta, sono incentivate a favorire l’inclinazione dovuta, per non restare spiazzate rispetto alla domanda, ovvero escluse dalle esigenze per cui certe voci sono facilmente assunte, magari per una proficua “giornata”, e altre no. Non conta più che un professionista esperto sia tenuto a bordo a lungo, e formato e preparato per intervenire con sicura competenza sui nodi sempre più ardui del governare contemporaneo. La funzione “terza” del giornalismo non interessa più. Meno che mai il prendere posizione, sia pure argomentato e provato, di giornalisti competenti, a mano a mano che le varie materie del contendere fra opinione pubblica e governo arrivano sui tavoli del dibattito pubblico. In questo caso, anzi, il giornalista già legato da un rapporto di fiducia con i lettori è una palla al piede, se per caso dissente dall’editore. E non puoi neanche immaginare un equipaggio fisso di bravi e competenti e noti giornalisti, disposti a seguire quell’editore in tutte le sue battaglie. Perché quelle battaglie possono durare un anno o un giorno, possono svanire con un accordo di cui non sappiamo nulla, possono continuare, ostinate, per un periodo protratto che chiederà interventi pesanti e ripetuti.
Vorrei a questo punto che i lettori si rendessero conto di due aspetti di questo scontro violento e difficile che sto descrivendo fra coloro che chiamerò “gli editori di adesso” e coloro che mi sembra giusto definire “i giornalisti di una volta”, ovvero coloro che si erano abituati a seguire il percorso della loro competenza e della loro esperienza. Vorrei anche che questo modo di descrivere le cose non sembrasse una celebrazione. È un fatto, però, che gli spazi hanno cominciato a restringersi drasticamente a seguito di una serie di movimenti sismici in tutta l’area della notizia. Interessi vasti e importanti si sono spostati verso i punti caldi dell’editoria. I punti caldi dell’editoria si sono addossati al potere economico. Il potere economico a volte è, a volte non è, un governo o tutto un governo. Ma chiede di essere rappresentato in modo vigoroso e istantaneo. Come se non bastasse, in alcune parti del mondo (prima di tutto in Italia) vi è stata un’aperta invasione di campo da parte di un’immensa ricchezza direttamente nell’area delle notizie, con l’effetto di impastare insieme un impero finanziario, un impero mediatico e uno schieramento politico. Però, per una volta, non è del conflitto di interessi di Berlusconi che intendo parlare – anche se, come molti, mi rendo conto del colpo che Berlusconi ha inferto alla già debole e delicata struttura del rapporto fra potere economico, editoria e giornalismo. Intendo prestare attenzione al problema in generale. Quel problema non nasce in Italia. Ricordo, al tempo in cui insegnavo giornalismo alla Columbia University (negli anni Novanta), la mia meraviglia quando ho appreso dell’esistenza di un «Comitato per la difesa dei giornalisti». Quel Comitato era coinvolto in molte situazioni drammatiche (l’arresto immotivato di un giornalista in un Paese, la scomparsa improvvisa di un giornalista in un altro). La base dell’esistenza del Comitato, però, si fondava su una definizione di rispetto e autonomia della professione, sulla realistica accettazione della qualità fastidiosa del mestiere, e sulla necessità di un monitoraggio continuo, più per garanzia del principio che per necessità urgente di intervento. In pochi anni la situazione è cambiata. L’assassinio di Anna Poliktovskaja a Mosca ci ha indignati, ma non ci ha sorpresi, tanto più che, nella sola Mosca, due altri giornalisti sono stati assassinati in due settimane. La Poliktovskaja aveva scoperto, descritto e documentato i delitti e le stragi delle truppe di Putin in Cecenia. Evidentemente anche gli altri – quelli uccisi prima, quelli ucciso dopo di lei – si sono scontrati con zone di potere che non hanno alcuna intenzione di subire il disturbo delle informazioni.
È stato il destino di Antonio Russo, di Ilaria Alpi, un destino preceduto dalla scomparsa di coraggiosi giornalisti italiani in Sicilia. La differenza tremenda è che giornalisti come De Mauro e Fava sono stati vittime del potere perverso e avverso della mafia. Adesso invece la perversione di eliminare i giornalisti viene dal centro di un potere riverito e ammirato dagli altri poteri del mondo. Basti pensare alla Cina, dove basta una riga sbagliata in una e-mail privata per farti sparire, o farti imparare a non ripetere l’impudenza.
Il Senato americano ha lottato a lungo contro la proposta dell’amministrazione Bush di istituire un centro governativo di valutazione e classificazione (secondo il grado di pericolo) dei vari articoli sui giornali o degli interventi in tutti i tipi di comunicazione, dalla Tv commerciale ad Internet. È vero che il pericolo del terrorismo può nascondersi dappertutto. È anche vero che i giornalisti, ormai, vengono visti – anche nelle migliori democrazie – come portatori del virus pericoloso di informare che, a quanto pare, sempre più interferisce col governare. Si dice spesso, in genere con ammirazione, che la Russia di Putin è un laboratorio non solo del futuro di quel Paese. Se è vero, il destino tragico e netto di Anna Poliktovskaja dovrebbe essere carico di messaggi. Come spesso accade, il percorso italiano sembra essere meno drammatico. Si chiede solo meno professionismo (l’età si porterà via un bel po’ di persone scomode, che insistono sui questa storia dei doveri morali della professione) e più precariato, un bel rimescolamento di carte, con tanti ragazzi e ragazze a ore che tagliano e incollano, o vanno in onda disinvolti e gradevoli a leggere strisce di notizie preparate da poche agenzie del mondo. Completate la scena con la gestione accorta delle voci autorevoli raccolte su piazza (le voci degli editorialisti e dei commentatori) da cui, di volta in volta, si può ottenere tutto e il contrario di tutto, considerato che sempre meno gente ha fatto la Resistenza e sempre meno gente la mette giù dura con i principi irrinunciabili della Costituzione.
Dubito – ma lo ha già detto chiaro il direttore di questo giornale – che si possa continuare a difendere il giornalismo con più scioperi. Il dramma si è già consumato prima, quando tanti colleghi, negli anni di Berlusconi, si sono sforzati di non sapere, di non vedere, di non criticare. Vi ricordo, per tutti, il giorno triste in cui un bravo e serio conduttore di un apprezzato e apprezzabile programma Rai mi ha invitato fra i suoi ospiti. In quell’occasione ho detto che «Berlusconi è una barzelletta che cammina», modesta affermazione polemica, assai più mite di ciò che ogni giorno Maureen Dowd o Paul Krugman scrivono di Bush sul New York Times. Vi ricordo che il bravo e serio conduttore della televisione di stato ha chiesto scusa ai telespettatori per la mia affermazione, come se si fosse trattato di una bestemmia. Segue, come nell’Isola dei Famosi, la squalifica per chi ha bestemmiato: fuori dal programma (persino dai «trailers» di pubblicità di quel programma), fuori dalla Tv di Stato. Giusto, no? Solo che gli editori – per inevitabile e naturale impulso umano – tendono ad approfittarne, come avviene sempre quando l’altra delle due parti a confronto si mostra cedevole. In altre parole, avere ceduto così tanto al potere politico, ai tempio di Berlusconi (certo come risposta a pressioni molto forti) diminuisce adesso la forza di tenere testa alle richieste radicali (e, nelle loro intenzioni, finali) degli editori.
Controprova. Nei giorni dello sciopero, tutti i giornali che noi definiamo «normali» (traduco dall’inglese: mainstream) non escono. Ma le edicole si popolano di tutto il sottobosco dei giornali e dei giornalisti di destra, che invece non scioperano. E di piccoli, orgogliosi giornali di sinistra che – apparendo accanto alla destra in edicola – si prestano a mimare la normalità democratica. «Ecco qui» – finisce per dire il frequentatore di edicole (un italiano su dieci) – «ci sono tutti».
Invece manchiamo tutti. Non sarebbe meglio ripensare al destino della libertà di stampa? Riusciremo a salvarla, mentre essa si deteriora quasi ovunque? Per quanto riguarda i giornalisti, tutto ciò che resta del futuro comincia da queste domande. O finisce qui.” (furiocolombo@unita.it)
 in Italy by
in Italy by