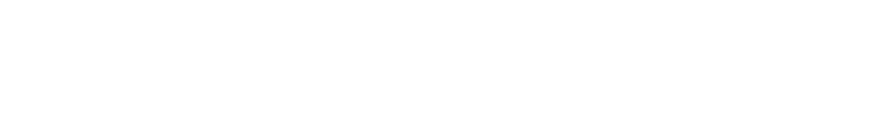L’appello di Paolo Butturini a esprimerci su ciò che dovrebbe contenere la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico è stimolante. Lo accolgo volentieri e invito a mia volta i colleghi giornalisti a intervenire…
Trovo particolarmente interessante il richiamo di Butturini al fatto che, anche se attraversiamo una fase difficile, con tutte le difficoltà economiche del momento, noi dobbiamo impegnarci a migliorare con il contratto la qualità dell’informazione. Sono pienamente d’accordo. Non è un richiamo astratto. E’ l’unico modo di salvare durevolmente posti di lavoro giornalistici nella situazione attuale in cui alla dequalificazione delle mansioni giornalistiche all’interno delle redazioni, all’espulsione di professionalità mature che non vengono sostituite, fa riscontro un serio scadimento dei contenuti giornalistici dei media, con l’inevitabile conseguenza di mettere in fuga lettori e spettatori e di far crollare ulteriormente le vendite e gli ascolti.
L’impoverimento dei contenuti propriamente giornalistici dei media, la sostituzione delle notizie con informazioni non-giornalistiche di vario tipo (gossip, infortainment, schede storiche, pubblicità mascherata ed altro) è una tendenza non solo italiana. Questo modo di ridurre i costi è un rimedio peggiore del male, perché snatura il prodotto, lo rende meno appetibile e in definitiva intossica i bilanci, rendendoli ancora meno sostenibili.
Di fronte a tutto ciò le parole d’ordine che ascolto mi sembrano ancora vaghe. Che significa dire: non c’è un euro, dobbiamo difendere i posti di lavoro? Si può difendere il posto di lavoro rinunciando alla qualità dell’informazione? Chiedo: se i giornali si faranno con le veline e con i comunicati stampa, le redazioni avranno ancora bisogno di giornalisti?
Dobbiamo riflettere bene su queste cose. Dobbiamo scegliere le mosse giuste sulla base di un’analisi più seria, più aggiornata e che tenga conto di tutti i problemi sul tappeto. Intendo: dobbiamo inserire nella riflessione alcuni seri problemi che finora abbiamo trascurato: ad esempio, la tutela legale del giornalista (dipendente e non) a fronte del dilagare inarrestabile di querele pretestuose e di richieste danni infondate che impongono ai singoli giornalisti costi di difesa incompatibili con le loro retribuzioni. Non credo si possa trascurare oltre questo delicatissimo problema. Sarebbe fra l’altro la continuazione della battaglia per l’equo compenso.
Io credo che sia venuto anche il momento di rappresentare in modo più adeguato le condizioni reali in cui oggi si svolge l’attività giornalistica nelle redazioni e la ripartizione dei carichi di lavoro interno ed esterno. Su queste cose è bene che finalmente si sviluppi un confronto.
Io vorrei che tutti avessimo presente un fatto che il nostro sindacato ha ben capito, sia pure in ritardo: oggi non dobbiamo fronteggiare solo gli effetti sull’editoria della crisi economico- finanziaria generale, come si era creduto in un primo momento, quando i prepensionamenti erano sembrati la panacea di tutti i mali. No, dobbiamo fronteggiare la fine del ciclo storico che ha garantito il finanziamento dei giornali con le vendite e la pubblicità. Dobbiamo perciò chiederci: Da dove possono arrivare le entrate che mancano? Può essere il settore pubblico e un imprenditore portatore di altri interessi a sopperire alle entrate che vengono a mancare? Non ne abbiamo discusso e dovremmo farlo. In altri paesi lo hanno già fatto e sono giunti alla conclusione che non va bene neppure l’editore puro, che loro hanno sperimentato e che noi continuiamo a vagheggiare. Di conseguenza in questi paesi stanno sperimentando nuovi modelli di impresa editoriale puntando sul no profit. Anche di questo, da noi non si è ancora parlato. Dovremmo cominciare a farlo.
Inoltre dovremmo comprendere bene quali problemi vecchi e nuovi del giornalismo e dell’editoria, in Italia, si sommano agli effetti più plateali della crisi economica e la rendono così grave. Credo che dovremmo avere la consapevolezza che molti problemi della categoria nascono dal fatto che, fin dal 1948, in Italia la legislazione sulla stampa ha un carattere punitivo nei confronti dei giornalisti. E, insieme, la consapevolezza, che negli ultimi anni la situazione è peggiorata e non solo perché i bilanci delle imprese editoriali sono andati pesantemente in rosso, ma perché la situazione è peggiorata a causa dell’aggravarsi di problemi che finora abbiamo considerato al di fuori del campo dell’iniziativa sindacale, primo fra tutti la difficoltà sempre più marcata di pubblicare notizie e inchieste scomode per i vari poteri.
E’ un fenomeno che ci siamo sforzati di non vedere, ma che adesso è sulla nostra strada e la ostruisce come un macigno. Il primo problema che ostacola la diffusione delle notizie è la limitazione del pluralismo e dell’autonomia causata dalla concentrazione delle proprietà in poche mani e dal conflitto di interessi ancora irrisolto, anzi complicato dalla recente acquisizione di una elevata quota del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera da parte della FIAT. Sui nostri giornali ci sono molte notizie, ma ne mancano altrettante che dovrebbero esserci. Una parte della realtà quotidiana è frugata con attenzione e professionalità, un’altra parte è soggetta a criteri ben diversi, come se si trattasse di un altro paese, un paese in cui la libertà e la completezza dell’informazione sono opzionali, facoltativi. In una parte del paese c’è una forte competizione sulle notizie e non c’è pericolo che qualche informazione di rilievo possa sfuggire o restare inedita. Le cose cambiano appena spostiamo il campo di osservazione dal centro alla periferia, dal centro delle grandi città alle periferie urbane, dalle metropoli in cui vengono stampati vari giornali e vengono messi in onda vari notiziari radiotelevisivi in concorrenza fra loro alle province e ai comuni. In questa seconda Italia, quasi sempre, c’è una testata che detta legge perché occupa una posizione dominante incontrastata e in virtù di questo esercita il potere di oscurare una parte delle notizie, rende l’informazione univoca, impone ai giornalisti una prassi difficilmente conciliabile con la deontologia.
Questa Italia che ci sforziamo di non vedere è sotto osservazione con viva preoccupazione da parte dell’intera Europa e delle istituzioni internazionali. Da dieci anni i più autorevoli osservatori internazionali assegnano un pessimo voto alla libertà di stampa vigente nel nostro paese. Le pagelle dicono che in Italia, nell’insieme delle due Italia che ho indicato, c’è una libertà di stampa “parziale”. Noi finora non ce ne siamo curati, ma guardate che non è una bazzecola. E’ un indicatore negativo che, ad esempio, gli investitori internazionali tengono in conto. Quando si decide se comprare o meno i BTP italiani non si guarda solo il PIL e lo spread. In base a queste pagelle il giornalismo italiano afflitto da una malattia grave.
Quello che viene assegnato all’Italia non è un bel voto. Ci amareggia, ci fa restare male. Ma invece di prendercela con chi ci dà quel brutto voto dovremmo cercare di correggere gli errori che lo determinano. Non mi pare che abbiamo fatto questo. In questi dieci anni abbiamo negato di essere malati. Ci siamo tenuti la ‘malattia’ senza curarla e senza guarirne.
Infine elenco alcune norme concrete da inserire nel contratto che illustrerò in un successivo intervento, se la discussione andrà avanti.
Riguardano in particolare, come ho detto, la tutela legale da parte dell’editore, attualmente non prevista dal contratto e che invece secondo me dovrebbe esserlo, considerando che l’uso pretestuoso e intimidatorio delle querele e delle citazioni per danni trascina sempre più giornalisti incolpevoli davanti ai giudici e li costringe a sostenere delle spese per colpe che non hanno. Altre proposte riguardano le misure necessarie da varare in attesa che siano approvate le riforme legislative indispensabili per permetterci dotarci di una assicurazione di responsabilità civile come tutte le altre categorie professionali (depenalizzazione, tetto dei danni esigibili, parametrazione delle sanzioni giudiziarie alle capacità economiche del singolo giornalista).
Altre proposte riguardano l’esperienza che ho maturato in questi cinque anni, con l’osservatorio Ossigeno per l’Informazione, sulle migliaia di intimidazioni che colpiscono i giornalisti italiani. Altre ancora riguardano la mescolanza fra notizie giornalistiche e pubblicità, tornata in forme nuove, più subdole e inquinanti. Altre riguardano il ruolo manageriale dei direttori che confligge con la deontologia giornalistica. Altre ancora riguardano la definizione di un nuovo mansionario e di nuove qualifiche in grado di fotografare la realtà organizzativa che si è creata nelle redazioni e che non è rispecchiata dal contratto vigente.
Mi auguro sinceramente che questi punti siano discussi, che le critiche – che metto nel conto – mi aiutino a inquadrare meglio le singole questioni.
Il rinnovo del contratto è una buona occasione per cominciare a parlare di tutte queste cose, per offrire alla categoria l’opportunità di riacquistare una credibilità messa seriamente in discussione. Spero sia anche un’occasione per contrastare con buoni argomenti la concezione politica e culturale prevalente in Italia, secondo la quale, a differenza di altri paesi, noi non ci possiamo permettere una stampa pienamente libera.
 in Italy by
in Italy by