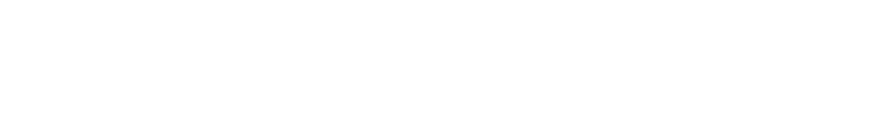No, Enrico. No. Il telefono non si spegne. Mai. Perché alla fine le notizie arrivano. E ti lasciano in brache di tela dentro a una fredda tempesta di sentimenti di ricordi di rimpianti di morte di vita. È arrivata solo adesso, il tempo di sciacquarmi la faccia dalle lacrime, la pessima notizia che Enrico è morto. Enrico Fierro, 69 anni, giornalista. Ex Unità. Ex fatto quotidiano. Da poco al Domani.
Ma quante altre cose. Eppure ho spento il telefono questo pomeriggio, e lo sapevo – anzi forse proprio perché lo sapevo – che stavi male, anzi malissimo, da settembre ricoverato per polmonite e successivo infarto, imprigionato dalla ragnatela di tubicini della terapia intensiva con diagnosi a catena di un paio di altre malattie che scoprivi di avere addosso. Per non farti mancare niente.
Lo sai. Che le notizie non si possono fermare spegnendo il telefono o con altri espedienti: ce lo dicevamo già la prima volta in mezzo a una bufera tanti anni fa, Ariano si chiamava il paese, Ariano Irpino, sede di un super-carcere che balzò nella notte con i suoi muri altissimi e le garitte bianche mimetizzate dalla neve davanti ai nostri occhi. Collaboravi con la Voce della Campania, rampante e squattrinato mensile di inchieste scomode, eri ancora “funzionario” – “rivoluzionario di professione”, scherzavamo, ma neanche poi tanto, visto che spesso lo stipendio saltava e anche quando… era una specie di nota spese – nell’organico striminzito della federazione PCI di Avellino.
Nell’Irpinia del pre-terremoto avevi fatto tante assemblee di braccianti e guidato vertenze contro lo spopolamento della montagna. Che si concludevano con un pasto a casa del segretario di sezione e una “mappata” di cibo per il ritorno. Nel dopo terremoto avevi visto e vissuto l’infiltrazione degli uomini in carne e ossa della camorra napoletana in una zona “pulita”. Il nostro servizio ad Ariano non era un granché rispetto a questi grandi temi, temi che erano grandi allora solo per l’Unità, non per la filosofia editoriale degli altri giornali. C’era la direttrice del carcere-modello scivolata in un’inchiesta camorristico-boccaccesca, per dirla con i cronisti pigri.
E tu che pigro non eri, ti beccasti una clamorosa piazzata della suddetta direttrice: “Enri’ tu qua trasivi e niscevi …. trasivi e niscevi”: tradotto significava che in qualità di dirigente di partito tu avevi avuto facilmente l’accesso al carcere e alle sue iniziative di socialità e ora ripagavi così la dirigente in disgrazia. Tu rispondesti con uno dei tuoi sorrisi eleganti arrotando le erre con la voce impastata di fumo. Suppergiù rivendicasti libertà di espressione e di critica, poi scrivemmo tanti pezzi divertenti, e festeggiammo a spese dell’Unità in trattoria. Al ritorno a Roma avvertii i capi del giornale che ad Avellino c’era uno tanto bravo, intelligente, colto, che pensava di scrivere sul mondo come se il mondo potesse essere cambiato. Citazione con perifrasi dal tuo amato Bertolt Brecht. (Alle ragazze del giornale spiegai che quell’Avellinese era anche bello). E dallo spettacolo e dai “media “saresti rimasto folgorato per tutta la restante vita: ci vedemmo spesso, ci sentimmo poi per telefono, non quanto avrei voluto, non quanto avrei dovuto: l’ultimo migliaio di sigarette lo bruciasti in giro per il meridione per uno spettacolo che inventasti nella tua furia civile contro la paradossale e tragica persecuzione da parte della cattiva giustizia e della cattiva politica di un uomo giusto come Mimmo Lucano.
E io ancora maledico il lockdown per avermi impedito di vederlo. Ecco, è morto un giornalista, un combattente. In una fase nella quale questa professione e quest’aggettivo non vanno più facilmente in coppia. Leggo già tanti accorati necrologi, che dicono dell’amore di tanti di noi per Enrico. Spero che non si associno ipocritamente al nostro lutto direttori e colleghi che osteggiarono Enrico e che Enrico combattè, lui con eleganti e affilate parole, gli altri con coltelli nella schiena.
Spero che tacciano quei “sindacalisti di categoria” che negarono o centellinarono la solidarietà per le battaglie giudiziarie che minacciarono economicamente e forse ancora minacciano Enrico e la sua famiglia. Guerre giudiziarie a colpi di querele e di risarcimenti che per lui e per quelli della sua pasta sono la continuazione della battaglia politica per un mondo migliore “con altri mezzi”. Altra citazione di concetti e parole che hanno fatto il loro tempo, Enri’, da quando “trasivi e niscevi” con le tue, le nostre speranze, nelle nostre vite.
Ps. Ed eventualmente salutaci Nuccio Ciconte non sia mai che qualcosa rimanga dopo la vita oltre ai nostri ricordi
Vincenzo Vasile
Ci ha lasciato Lanfranco D’Onofrio, il decano dei cronisti
Ci ha lasciato Lanfranco D’Onofrio, il decano dei cronisti di ‘nera’della capitale per anni punto di riferimento dalla sala cronisti della Questura di Roma.
È morto a 96 anni dopo una vita passata a raccontare i fattacci di nera. Il lavoro da giornalista lo aveva iniziato a 19 anni per L’Unità, poi era passato a Paese Sera e, in seguito, iniziare a lavorare per Repubblica dove ha collaborato fine agli ultimi anni.
I colleghi lo chiamavano affettuosamente “L’Imperatore” e negli anni si era guadagnato la stima di poliziotti e carabinieri per la sua correttezza e professionalità.
D’Onofrio è stato testimone di tutti i più grandi gialli e avvenimenti di nera che sono avvenuti nella capitale sin dal dopoguerra e fino ai nostri giorni.
Dal giallo della morte di Wilma Montesi, alla decapitata del lago di Castel Gandolfo, dal delitto Casati Stampa, al sequestro di Aldo Moro e gli attentati degli anni di piombo, fino ad arrivare al delitto di via Poma, il giallo poi risolto dell’Olgiata, l’omicidio Marta Russo e del giuslavorista Massimo D’Antona.
Per il Sindacato Cronisti romani ha ricoperto varie cariche, per anni ne è stato tesoriere, così come per l’Unci, l’unione dei cronisti italiani.
Lascia la moglie Serena e i figli Rosangela e Andrea ai cui va l’abbraccio di tutti i cronisti.
I funerali si svolgeranno giovedì 11 novembre 2021 a Terracina, alle ore 11 presso la Concattedrale di San Cesareo.
Morto Lanfranco D’Onofrio, il ricordo di Massimo Lugli
«Come andiamo, dottò?»
«Alla marinara, molta acqua e pochi pesci».
Ce lo siamo ripetuti tutte le mattine, spesso a orari inconcepibili, per anni, per decenni. Lanfranco D’Onofrio, la sua voce, le sue battute, la sua presenza costante, inamovibile sul posto di lavoro, era una certezza.
Probabilmente la persona con cui ho scambiato più telefonate, più notizie, più spunti di lavoro in vita mia, da quando, a 19 anni, entrai nella redazione di “Paese sera” fino al momento di andare in pensione da Repubblica, quarant’anni più tardi.Era sempre lì. Nella sala stampa al primo piano della questura Lanfranco, più che un decano, era un monumento. Per la sua scrivania sono passati i fatti e i fattacci di cronaca nera più clamorosi dell’ultimo mezzo secolo e passa.
Ed era la sua voce, quella voce perennemente velata da un filo di ironia e di bonomia tutta romana, che a volte di svegliava nel cuore della notte, ti catapultava all’improvviso da un capo all’altro della città. «Dottò, hanno appena rapito Moro, si hai capito bene, Aldo Moro» «Dottò, hanno ammazzato una ragazza a via Poma, corri». «Dottò hanno sparato a una studentessa all’Università…».
Tra le migliaia e migliaia di input che ho ricevuto da Lanfranco, dai tempi dei telefoni a rotella e delle macchine da scrivere fino a quelli dei cellulari e dei computer, ne ricordo uno particolarmente curioso quando mi bloccò sotto un diluvio scrosciante, in motorino, diretto a una conferenza stampa da due colonne in taglio basso. «Dottò, ascolta bene, non è uno scherzo, sono scappati un leone e due tigri da un circo di Primavalle, stanno in mezzo alla strada, datti una mossa».
Rigoroso, puntuale, preciso, schivo. Nipote del dirigente del Pci ed ex partigiano Edoardo D’Onofrio, Lanfranco ha sempre mantenuto una profonda convinzione politica parallela al suo impegno professionale e sindacale.
Iniziò all’Unità, diciannovenne come me agli esordi, per poi passare a Il Paese che, successivamente, divenne “Paese sera” e, come tanti di noi, entrò, da collaboratore, a Repubblica quando la testata fu chiusa. Raramente lo si vedeva in redazione, la sua postazione era in Questura, con quei colleghi che scherzosamente noi neristi definivamo “i trombettieri” e che, in tempi in cui i rapporti tra investigatori e stampa erano incrostati di diffidenza e pregiudizi reciproci, erano l’unico accesso possibile alle notizie.
E di notizie Lanfranco ne scovava parecchie, mai accontentandosi delle “veline” da ufficio stampa ma frugando, indagando, scoprendo, svelando spesso segreti destinati a restare tali. «Inguattati», come diceva lui. Molto riservato sul piano personale, parlava pochissimo della moglie Serena e dei figli Rosangela e Andrea, la sua adorata famiglia. Cuore da alfista, aveva una passione per le macchine veloci e una tendenza a pestare forte sull’acceleratore. Fu uno dei fondatori del Sindacato Cronisti, uno dei dirigenti più attivi, sempre pronto a battersi per la dignità della professione. Il tesserino rosso scuro dell’Ordine per Lanfranco non era un simbolo ma un impegno, una fede.
Quando una persona arriva a superare i 90 anni spesso ti aspetti la notizia che mi è arrivata poco fa e che sta rimbalzando tra telefonate e messaggi tra i colleghi con i capelli bianchi come me, che lo hanno conosciuto ma non per questo ti lascia meno attonito e addolorato. Oltre a tanti flashback, tanti ricordi e a tantissimi insegnamenti, all’esempio e all’affetto reciproco, di Lanfranco mi resta un regalo singolare: le due pistole che mi donò quando decise di non andare più a sparare al poligono: «Prendile tu che ti ci diverti». Le ho usate pochissimo, ormai superate da armi più precise e moderne. Le conservo come un cimelio.
di Massimo Lugli

 in Italy by
in Italy by