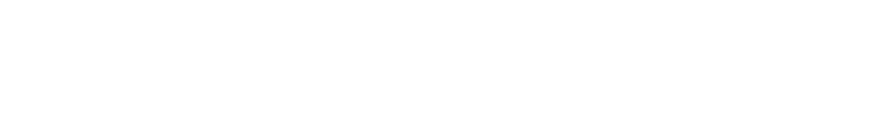“Nel lavoro giornalistico l’elemento caratterizzante la subordinazione è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale”. Lo dice la sentenza n. 22872 della Cassazione, dello scorso 9 settembre. Lo “stabile inserimento” diviene dunque il principio con cui riconoscere le tipologie di lavoro giornalistico cosiddetto subordinato: circoscrivendo, di conseguenza, le attività “sostanziali” (più inquadrate e tutelate) rispetto a quelle “accidentali” (più aleatorie).
Dove devono collocarsi i collaboratori (o, almeno, una buona parte di essi)? Ovvero, cosa si deve intendere per “stabile inserimento”? Risponde, più avanti, la sentenza: “Né rilevano il luogo della prestazione lavorativa, che può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in un’attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni”. È esattamente ciò che accade oggi ad una crescente quantità di colleghi collaboratori, definiti ancora “esterni” (e privati di tutele).
Un pronunciamento forte, quello della Cassazione, che ha avuto pochi riverberi nelle discussioni sindacali in corso, almeno in quelle di pubblico dominio. Forse perché i cosiddetti “freelance” non hanno peso in seno alle interne dinamiche di potere che (legittimamente) animano, come accade in ogni organizzazione, il nostro sindacato.
Eppure, ragionando in modo lungimirante, quella sentenza è, una volta di più, un riconoscimento lampante per molti dei giornalisti, spesso eccellenti professionisti (quale che sia la loro collocazione negli elenchi dell’albo), che esercitano in regime di “autonomia” (ovvero di para-subordinazione). Sono ormai una maggioranza silenziosa, che vive di fatto come parte delle redazioni, ma in termini di diritto ne è ancora respinta all’esterno.
Il sindacato sta faticosamente recependo le istanze del lavoro “autonomo”, tentando, con scarsissimi risultati, di porre rimedio ai suoi molti problemi nel rapporto con i colleghi graduati e con gli editori. Ma intanto lo stesso sindacato non può esimersi dal promuovere almeno una più completa impostazione interpretativa della questione: va liberato il campo, insomma, dalle vecchie categorie, quelle basate su un declinante modello di redazione, ormai prive di pregnanza conoscitiva e di efficacia operativa. E non si tratta di chiedere utopistiche assunzioni di massa.
Come la menzionata sentenza della Cassazione afferma e prescrive, i rapporti redazionali, anche a livello di qualità professionale, non sono più leggibili alla luce delle tradizionali dicotomie interno-esterno, assunto-collaboratore. Ed è sacrosanto, perché oggi la macchina dell’informazione procede sempre più per comparti paralleli e integrati, aventi pari dignità: per dirla con termini in uso nel mondo anglosassone, il news-gathering (l’editing) e il news-writing (reporting). Ovvero la sfera di attività riconducibile all’assemblaggio e al confezionamento del prodotto giornale e quella relativa alla genesi testuale delle notizie. Quest’ultima sta diventando sempre più appannaggio dei collaboratori, come è evidente.
In tal senso, chi sta all'”esterno” (come si diceva ieri), cioè il collaboratore, svolge un lavoro altrettanto fondante e basilare: il radicamento nella multiforme realtà, la selezione e analisi dei fatti e la loro configurazione secondo “notiziabilità” (le famose proposte alla redazione: oggi a costo zero e che spesso vengono usate impropriamente, quando non rubate del tutto, nel completo silenzio dei cdr).
Dunque, anche per la categoria del news-writing (o come altro la si voglia chiamare) si può e si deve ipotizzare, contro la giungla di adesso, un’organica gamma di diritti e tutele: a cominciare dalle retribuzioni e dall’anzianità. Oggi, sul mercato, un collaboratore con 20 anni di esperienza vale come uno che ha cominciato da una settimana. Un assurdo. L’iscrizione all’albo, sempre che le procedure siano credibili, non potrebbe servire a stabilire un’anzianità di massima? Ci potrebbero essere, così, reporter semplici e “senior reporter”, cioè reporter esperti che come tali devono essere trattati. Sarebbe una garanzia importante per gli stessi lettori, che in misura crescente disertano le edicole.
Alla luce della più attuale interpretazione del lavoro redazionale, che tiene anche conto dell’ormai massiccio impiego del tele-lavoro (la redazione “immateriale” al cui interno siedono quotidianamente i collaboratori), il sindacato deve ragionare e agire diversamente: lo sta facendo da tempo, deve farlo ancora meglio e più in profondità. Soprattutto a partire da quella preziosissima rete di rapporti personali e umani che sono le redazioni, i cdr e le Associazioni della stampa. Il contratto di categoria, prima o poi, verrà forse fuori. Ma dobbiamo evitare che la sua ombra (sorta di “Aspettando Godot”) sia di avallo ad una quotidianità sempre più de-regolata e soprattutto ipocrita.
Perché sono proprio quei menzionati rapporti tra colleghi, con l’impegno interpersonale che essi dovrebbero comportare (art. 2 della legge sull’Ordine del 1963), a serbare un forte potere di condizionamento migliorativo nel lavoro quotidiano e nelle dinamiche di redazione. Si può e si deve proseguire da qui, un elemento che chiama in causa la responsabilità di ciascuno: anche e soprattutto dei molti “interni” che gestiscono i collaboratori.
Sempre che i diritti ormai acquisiti, quelli dei subordinati di un tempo, non impediscano a nuovi ed essenziali diritti di sbocciare. E andrebbe forse affrontato con serenità e realismo, nell’intento di comporlo, quello che rischia di essere un conflitto generazionale esiziale all’intero dello stesso sindacato. Bisogna guardare avanti e comporre con ampiezza di vedute le istanze che provengo dai vari settori della professione: evitando che si divarichino tanto da portare all’insanabile rottura.
 in Italy by
in Italy by